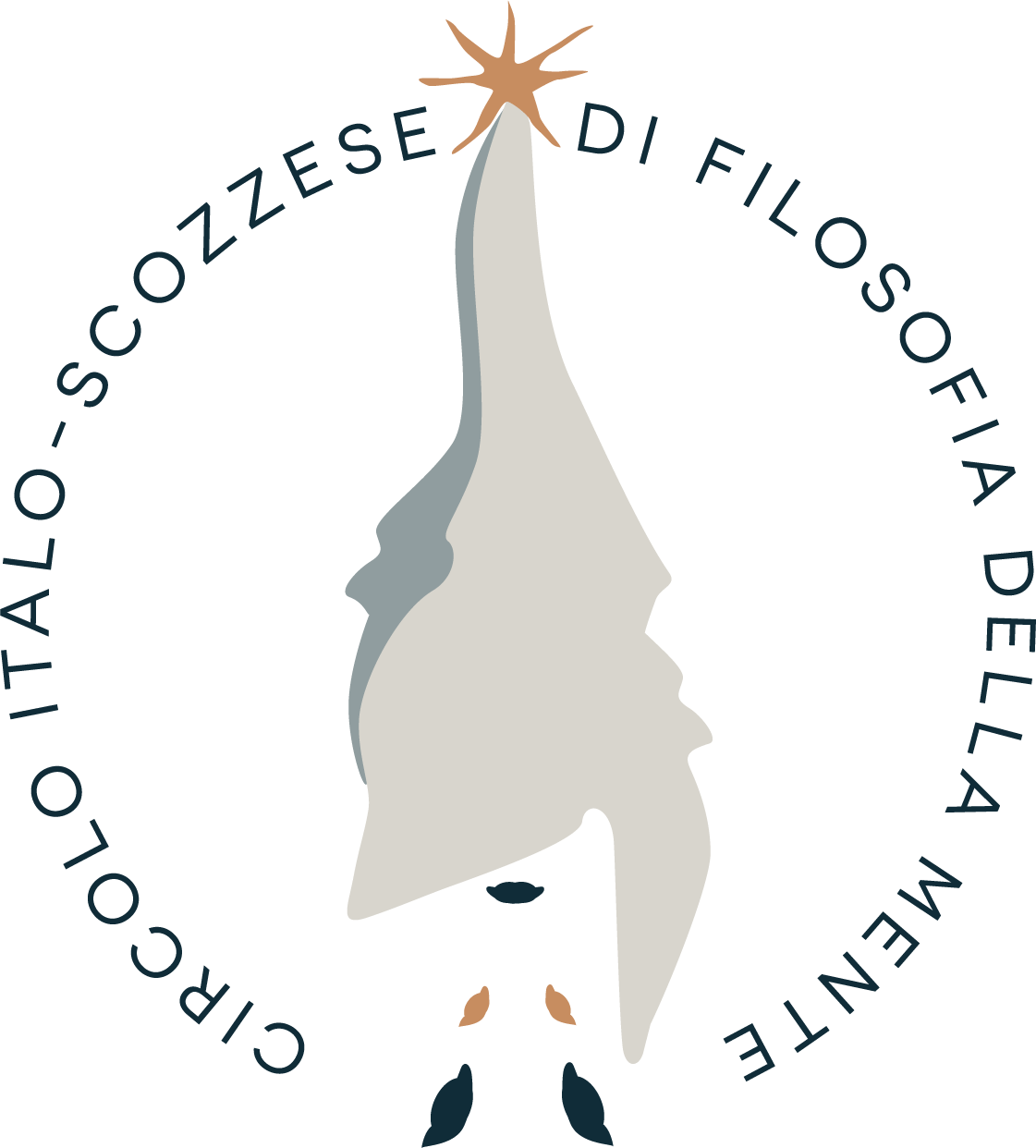Vita Nova
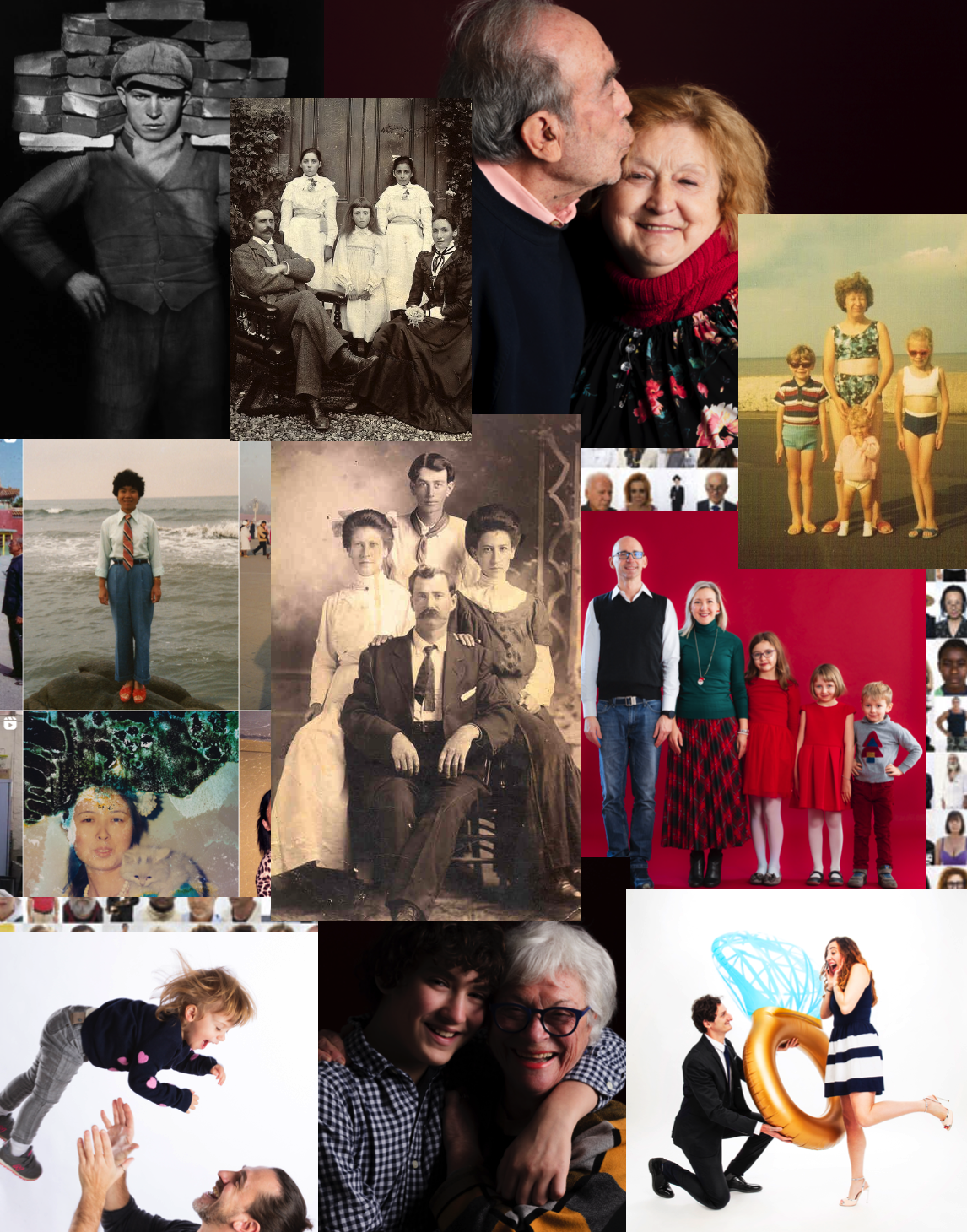
Secondo il sociologo tedesco Hartmut Rosa, ciò che più conta è ‘entrare in risonanza’ con le cose, le persone, le situazioni, con il mondo. Ma per entrare in risonanza con qualcosa è necessario che non tutto sia alla portata, che vi sia della ‘indisponibilità’. Per i nostri bisnonni, e in parte anche per i nostri nonni, la memoria fotografica era sufficientemente indisponibile e le foto di famiglia erano un evento, un rito da ricordare negli anni. Oggi non solo le foto- e i video-ricordo sono alla portata di tutti in qualunque momento, ma possiamo anche, per il nostro ghiribizzo, alterare la realtà creando immagini statiche o in movimento di scene che non sono mai accadute. È tutto super-disponibile, ma che ne è, che ne sarà dell’agognata risonanza? I nostri figli e nipoti potranno anch’essi entrare in risonanza con le nostre spettacolari quanto false immagini-ricordo?
di Paolo Tangari
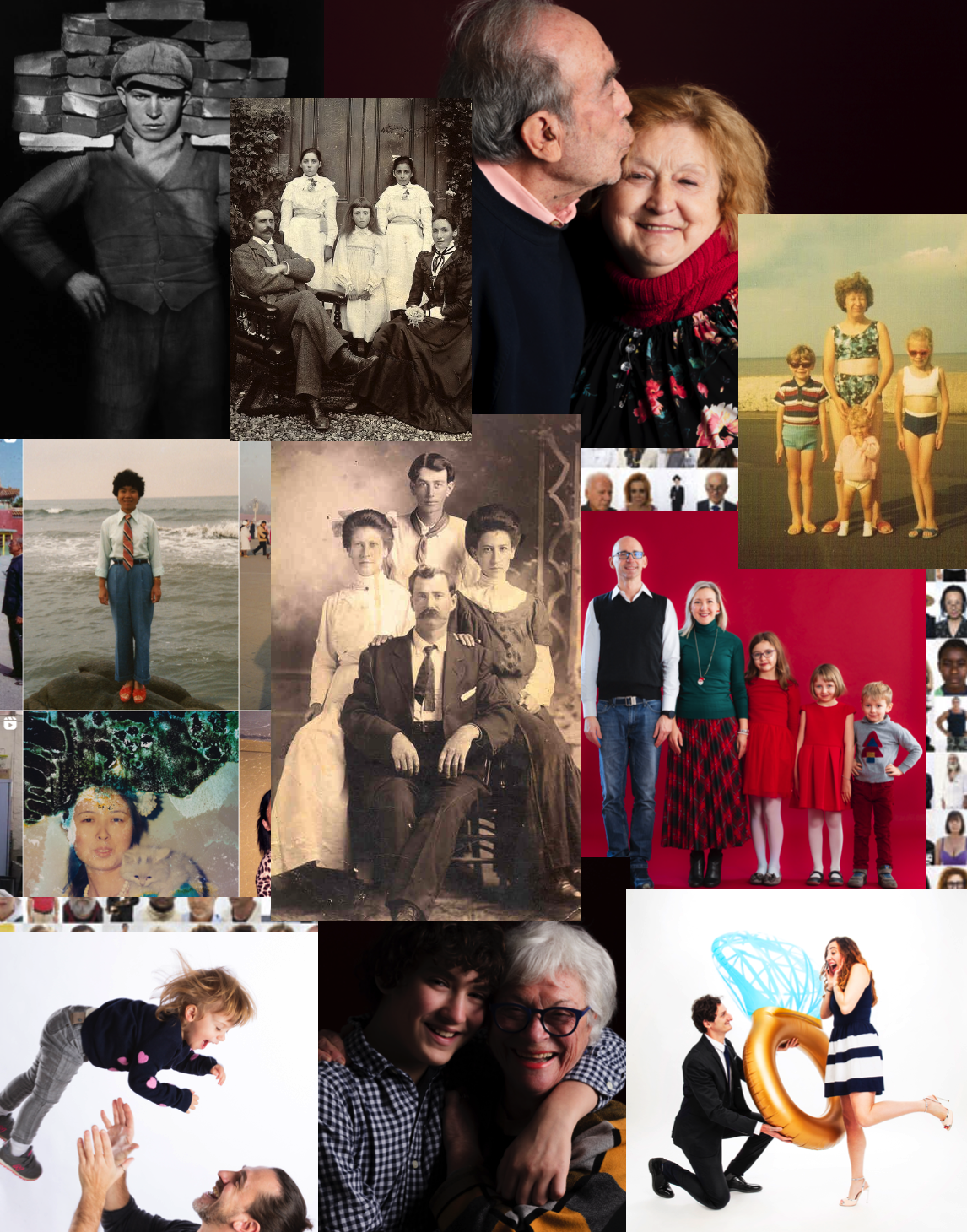
Composit di immagini dall’album di famiglia dell’autore
CI FACCIAMO UNA FOTO?
Durante alcune recenti peregrinazioni social, mi sono imbattuto in un gruppo Facebook che ha colpito la mia attenzione, e innescato riflessioni bizzarre.
Nel suddetto gruppo gli utenti postano vecchie fotografie di parenti, genitori, nonni o amici ormai scomparsi, e altri gentili utenti si occupano di animare queste fotografie, grazie all’intelligenza artificiale, e farle rivivere.
“Questa è la mia mamma negli anni 50 in una foto dal suo viaggio di nozze con papà, mi piacerebbe rivedere i miei genitori abbracciarsi ancora una volta!” e, poco dopo, qualche altro gentile utente le risponde con un breve video in cui la vecchia fotografia ingiallita, come per magia, prende vita, e i suoi genitori, da una posa statica e congelata nel tempo, si esibiscono in un abbraccio mai avvenuto, e immaginato da un calcolo matematico a forma di pixel colorato, il tutto con una musichetta di accompagnamento in sottofondo.
“Questo è mio fratello scomparso 40 anni fa, mi piacerebbe vederlo sorridere ancora una volta”. E il caro estinto, ad esempio, si toglie il casco da moto al rallentatore e guardando in camera sfoggia un sorriso consolatorio, stupendosi anche per un secondo di essere “filmato”, come nel più classico dei video “rubati” tra amici.
Che il potere delle immagini spesso travalichi la capacità di ragionamento oggettivo è cosa nota, e che il potenziale dell’AI generativa sia pressoché illimitato è una novità recente a cui ci siamo abituati molto in fretta.
Il mix di queste due cose, i dubbi e i rischi che solleva nella futura convivenza civile, è l’elefante nella stanza con cui stiamo rimandando l’inevitabile confronto.
È un tipo di fruizione delle immagini che mette in gioco moltissime cose che hanno un impatto reale nelle nostre vite, singole e come comunità.
Vorrei però soffermarmi in questa sede su un aspetto particolare, partendo dall’esperienza nel gruppo di cui sopra: la dimensione del ricordo intimo, ovvero, il nostro rapporto con la fotografia famigliare.
Nel giro di un secolo siamo passati da due estremi opposti, che muovono corde da cui la nostra “formazione”, come esseri umani e persone, a volte, dipende.
Faccio un breve percorso personale a scopo chiarificatore, solo perchè mi assicura un resoconto verificato degli eventi. Mia nonna Maria era nata nel 1925. Di lei ricordo alcune bellissime fotografie, che sono il mezzo con cui ho “dato vita fisica alla persona di mia nonna nella Storia” prima del mio arrivo su questa Terra. Non c’ero quando era ragazza, o quando si è sposata, ma ho esperienza empirica della sua vita tramite dei ricordi che lei ha scelto di pianificare, realizzare e conservare. Tra la dozzina di cornici che aveva sparse per la casa, ricordo una foto di lei giovane con i suoi fratelli, una fotografia del matrimonio con mio nonno, una foto al matrimonio di mia zia, una alla cresima di mio padre, e poi una serie di fotografie di lei, già anziana, con noi nipoti. Conservava anche due ritratti di sua madre, la bisnonna Grazia, nata nel 1897, un anno prima che nascesse il Cinema, in una scatola di latta con ricordi di parenti e amici vari. In tutto un centinaio di fotografie, stampate e conservate come solo una nonna può fare.
I miei genitori, nati agli inizi degli anni 50, avevano una bellissima Olympus OM-1 con cui per quaranta anni hanno fotografato la loro e la mia vita, riempiendo una decina di album che mia madre conserva a casa, dove devo andare fisicamente se voglio guardare “Vacanze Sicilia 1986” o altri eventi all’epoca considerati degni di nota. In tutto un migliaio di ricordi stampati, che negli anni abbiamo imparato a conoscere a memoria a forza di guardarle, riguardarle e riderci su, mentre la carta Kodak ingialliva.
Mia figlia, che ora ha 7 anni, compare in 10.512 fotografie che conservo su telefono e cloud. Una quantità simile di sue immagini sono probabilmente nel telefono di sua madre e dei suoi nonni, che dalla Olympus sono passati all’Iphone con un colpo di spazzola all’inizio di questo secolo.
Fino a qui storia nota, credo che più o meno tutte le persone che rientrano in qualcuna di queste generazioni abbiano un percorso “fotografico” molti simile.
È normale, siamo fatti di memorie, ricordi che nel tempo abbiamo imparato a rendere fisici, tangibili, classificabili. E deperibili.
Da questo punto di vista la scatola di latta della nonna e il mio hard disk non sono molto diversi, l’approccio è il medesimo: scegliamo gli scatti più belli e buttiamo quelli con gli occhi chiusi o troppo scuri; cataloghiamo, conserviamo questi ricordi alla stessa maniera, che siano su carta fotografica o in pixel.
Una volta mettevamo etichette sugli album, ora rinominiamo cartelle, ma il principio è lo stesso. Diamo all’oggetto digitale e “intangibile” la dignità della reliquia fisica. O almeno, lo fanno quelli che, per passione, per affetto, per cura, fruiscono lo strumento fotografia come un catalogo di ricordi, e non solo come una sequela di “appunti visivi”.
Tornando alla nonna, ho scritto prima che “ha scelto” di farsi fare quelle fotografie. All’epoca in cui era giovane, o ancora di più all’epoca della bisnonna, avere una o due fotografie era già una cosa speciale. Farsi fare un ritratto, per la maggior parte delle persone, era una cosa decisamente costosa, richiedeva una serie di azioni concrete tra cui abbigliarsi a dovere, sistemare i capelli, andare nello studio del fotografo, posare e aspettare (è una storia lunga e affascinante questa dei primi fotografi ritrattisti, e del loro pubblico, che meriterebbe un articolo a parte).
Una volta ricevuta la fotografia stampata si sceglieva una bella cornice, le si dedicava uno spazio in casa, bene in vista, magari in salotto. Era un piccolo evento, un rito, in un’epoca in cui spesso l’unico modo per “vedersi” era stare davanti allo specchio.
E soprattutto era irripetibile; dal momento in cui ce l’avevano in mano, gli esseri umani in quelle fotografie erano diventate un ricordo ben preciso. L’iconografia delle persone, e quindi il racconto che volevano di loro stessi, era ben codificato. Le pose erano quelle tipiche del ritratto “da studio”, o posato, che dir si voglia, in un rituale preciso, consolidato e, a quel punto, popolare.
Il soggetto è conscio di essere fotografato, quindi partecipa attivamente mettendo a favore di camera la sua “posa migliore”; anche perché non ne farà molte altre nella sua vita, anzi, era probabile che la stessa fotografia se la portasse letteralmente fino alla tomba, sulla lapide. Quindi erano tutti eleganti, col vestito della festa, seri, composti, a volte seduti con bambini in braccio, spesso in piedi. Pose che a loro volta derivavano dalla pittura, dai ritratti di re, signori e potenti; il classico ritratto di famiglia, una volta appannaggio dei soli nobili, adesso era anche alla portata del fornaio del paese.
Non era una cosa che si faceva con leggerezza. Richiedeva tempo, risorse, sincero desiderio. Oggi non richiede nulla, è alla portata di tutti, gratis, democratico, popolare. Non ha nessun costo, nessuna velleità artistica o sentimentale, se non “registrare un momento” tra mille altri. E richiederà sempre meno, motivo per cui possiamo essere tante cose diverse in quelle fotografie, perché si possono manipolare o cancellare, senza il minimo sforzo. Apparentemente il singolo scatto, ripetibile e perfettibile all’infinito, non ha nessun valore, economico e sentimentale, perchè la quantità smodata e la riproducibilità tecnicamente illimitata non gli conferiscono la caducità che appartiene alle memorie.
Siamo i nostri ricordi, si dice, quindi siamo le nostre fotografie. Solo che ci prestiamo meno attenzione di prima, o gli diamo un’importanza diversa. Una volta fotografavamo i momenti speciali, da anni fotografiamo tutto. Ma nel momento in cui tutto è speciale, niente lo è davvero. Oggi però siamo a una svolta. La tecnologia ci consente di creare un racconto bellissimo, anche di cose mai successe, da lasciare ai posteri, con dei protagonisti grandiosi: noi stessi!
PIÙ REALE DEL REALE
Facciamo un passo indietro.
All’avvento della Fotografia la caratteristica più prominente che la oppone alla pittura e alle altre arti figurative è il suo intrinseco valore documentale. Quello che fotografiamo esiste. È concreto, tangibile, empirico, inconfutabile. In una parola, “reale”. Attenzione, non vuol dire che tutto quello che la fotografia ci racconta sia vero, ma per una questione puramente fisica deve capitare davanti all’obbiettivo, deve esistere; un problema che per esempio non riguardava la pittura. Posso inscenare l’omicidio di Giulio Cesare con degli attori, che ovviamente non sarebbe vero, ma quegli attori devono fisicamente comparire davanti all’obbiettivo. Almeno, fino a ieri era così. Quindi, come diceva Ferdinando Scianna, “La fotografia mostra, non dimostra”.
Eppure nel suo primo secolo di vita la Fotografia è stata portatrice di indiscussa realtà, ci ha mostrato il mondo, la storia, gli eventi, le guerre e l’informazione. Certo, è sempre stata manipolabile fin dagli inizi e sempre lo sarà, ma per buona parte del secolo ci siamo fidati, e abbiamo relegato la manipolazione della realtà a segmenti del mondo che, si, ci riguardano, ma non da vicinissimo, non tra le mura domestiche. Al massimo cancellavano Trotsky dalle fotografie del Partito, non mia zia dalle foto del compleanno.
A differenza di tutte le altre immagini che ci passano davanti agli occhi, tipo la pubblicità, l’informazione, la propaganda o il cinema, la fotografia famigliare è sempre stato il luogo della nostra realtà, degli affetti, della memoria inconfutabile. Quelle persone nelle foto in casa siamo noi stessi, il micromondo in cui le bugie della manipolazione tecnologica non entrano. Insomma, anche il più fervente sostenitore del finto sbarco sulla Luna messo su pellicola da Kubrick, non metterà in dubbio le foto di sua nonna da giovane. O si?
In uno dei testi fondamentali sul linguaggio fotografico, “Sulla Fotografia” (1973) di Susan Sontag, l’autrice ci ammonisce su come le fotografie non siano solo uno strumento di registrazione dei ricordi, ma li costruiscano e talvolta li sostituiscano. La fotografia è «sia una pseudo-presenza che un’indicazione di assenza», la usiamo per creare una presenza artificiale del passato proprio perché quel momento non c’è più. Questo è centrale per capire perché le immagini diventano luoghi di nostalgia e di rielaborazione del lutto o della storia, collettivi e individuali. Come nella caverna di Platone vediamo il mondo in funzione delle immagini che ne vengono fatte.
RITORNO AL FUTURO
Ora la tecnologia ci consente, tramite le immagini, di vivere potenzialmente per sempre, ma ricreandoci sulla base di un algoritmo. Nelle immagini riportate in vita dall’intelligenza artificiale, non siamo più il ricordo di noi stessi, ma quello che potremmo essere, se… Sono immagini di cose che sappiamo non essere mai successe, anzi, stiamo intenzionalmente chiedendo alla tecnologia di raccontarci una bugia, là dove una volta vigeva solo la verità. E queste immagini ci consentono di modificare i ricordi, e quindi la realtà, a nostro piacimento, e permettono ad altri di farlo per noi, anche dopo che saremo morti.
Ci sono multinazionali che da anni sviluppano tecnologie e servizi in tal senso. Hanno nomi molto delicati ed eterei come ReMemory, ReLiveable, Eternos, Herefater… Se uno guarda i loro siti senza farsi cogliere da sconforto, sembrano normali piattaforme di streaming, servizi e abbonamenti, invece di essere un sito di onoranze funebri digitali. Uno degli slogan è che il servizio “ti permette di vedere e sentire i tuoi genitori come erano nelle loro adorate foto, piuttosto che immaginarli”. “Con solo una foto e un file vocale o un video con audio, puoi riunirti con i tuoi cari. Prova l’emozione sincera di incontrarli di nuovo”. Wow.
Se fossi il loro copywriter aggiungerei “E puoi anche scegliere solo le parti più belle!”. Giusto per far rigirare Freud nella tomba un paio di volte.
Il servizio offerto raccoglie dati e digitalizza quante più informazioni possibili su una persona, per crearne una vera e propria copia virtuale, che risponda con dialoghi pre-registrati o, nelle versioni premium, con dialoghi interattivi basati su campioni della voce reale. Spiegata in breve, quando muori raccolgono le centinaia di migliaia di selfie, video e storie dai tuoi archivi o canali social, e creano una tua copia tipo fantasma di Star Wars, con l’aspetto ricostruito dalle immagini del tuo profilo Instagram. Pensateci, quando fate la bocca a culo di papera nelle foto.
E come saremo fatti in questi avatar? Che aspetto avremo? Quello di quando eravamo giovani o di quando siamo morti? Lo sceglieranno i nostri cari?
“Ti ricordi che papà per un periodo aveva avuto la barba, gliela facciamo mettere? Stava così bene…”
“Come la facciamo la nonna? Io me la ricordo com’era bella da giovane..” “Ma mamma, con la versione premium possiamo switchare i nostri profili tra la nonna da ragazza e la nonna da vecchia come l’ho conosciuta io! Facciamola, dai!”.
Insert coin.
È lo straziante processo di dover scegliere una foto per la lapide di un caro estinto, ma all’ennesima potenza, parlante e animata, tra migliaia di scatti ricombinati. Una volta creato l’avatar, in base alle diverse offerte, si potrà avere un incontro standard col defunto che ripete la battuta di quel video, o anche un dialogo interattivo con la sua voce perfettamente riprodotta. Si potrà visitare in luoghi deputati dall’azienda o portare a casa, come un’urna funeraria, e portare in giro, come un’app sul telefono. Dipende tutto da quanto volete spendere, per ora, e dalla mole di immagini che gli avete dato in pasto, che produciamo quotidianamente a ritmo esponenziale. Tornando all’esempio generazionale, quando mia figlia sarà nonna magari farà vedere ai suoi nipotini il mio avatar, e ho difficoltà ad immaginare cosa potrà dire a quei bambini questo mio “io digitale”, ispirato dalle fesserie dei miei canali social. Non ci ho pensato fino a ieri. Un conto è un pubblico di sconosciuti contemporanei, un conto sono dei pronipoti non ancora nati.
Io ora sono la pecora Dolly di questa trasmigrazione digitale, ma forse già mia figlia, o i suoi figli, da adulti avranno contezza di questa cosa, e la loro generazione inizierà a creare una nuova narrazione famigliare per i posteri, veicolata attraverso il loro alter ego digitale post mortem. Magari ci penseranno due volte prima di fotografarsi sempre e solo in spiaggia all’aperitivo, e quello è un bene. Ma forse vivranno loro stessi con l’angoscia del ricordo che resta, non mediato dall’affetto, ma “freddamente” registrato e rimodulato da un software.
E quanto sapremmo essere sinceri nel regalare la nostra storia all’imperitura memoria digitale? Potrei avere un nonno antipatico e burbero, ma ora posso trasmettere ai miei nipoti un ricordo rivisitato, per fargli credere che fosse un vecchietto amorevole. Magari i miei zii non si sono parlati per anni, ma volendo potrei creare una narrazione post mortem improntata sulla famigliola felice e affiatata. Libertà totale.
Com’è stato dal dagherrotipo per pochi, alla macchina reflex per tutti, la versione low-cost arriva e diventa un codice, come abbiamo visto nel gruppo Facebook in questione. Si pongono quindi, a mio parere, due problemi; uno individuale e, di conseguenza, uno collettivo.
THE SHOW MUST GO ON
Le immagini possono dominare e semplificare narrazioni complesse; così come immagini semplici possono innescare riflessioni ardimentose. L’esposizione ripetuta a certe fotografie, per esempio di guerra o sofferenza, rischia di addomesticare la percezione morale dello spettatore, trasformando ricordo e impegno in spettacolo. Susan Sontag affronta anche questo tema, e la sua rilevanza per il consumo di massa delle immagini, oggi più che attuale. Semplificando, ad esempio, nel 1945 bastarono meno di una decina di immagini sgranate per instillare nell’umanità il terrore della bomba atomica, e su quella paura ci abbiamo fatto 40 anni di Guerra Fredda e ideologie totalitarie, tra le altre cose. Oggi scrolliamo foto di catastrofi e genocidi tra la sponsorizzata di un albergo e i consigli di cosmetica, e probabilmente ci siamo “anestetizzati” alla vista della violenza, alle brutture del mondo, da stupircene, e ricordarle, sempre meno. O meglio, ci ricordiamo “solo le foto”, ma non le storie che si portano appresso. La bulimia di immagini ci ha reso insensibili a tante cose, tra cui la guerra.
Ma cosa succederà quando saremo anestetizzati alla perdita? Perchè migliaia di bambini morti non ci toccano, ma la morte di un genitore, di un fratello, di un’amore, è un’altra cosa. Spesso quando parliamo di qualche defunto, ci manca istintivamente l’interazione. Sentiamo la mancanza dei gesti, della voce, dei sorrisi. “Chissà cosa avrebbe detto mia madre di questo vestito?”, “Ti ricordi il nonno con quella sua risata contagiosa?” La lontananza nel tempo, il ricordo, la coscienza dell’impossibilità di vivere, assaporare ancora una volta quella certa sensazione, relega il dolore nella sfera di qualcosa che manca proprio perchè non è ripetibile.
La parola nostalgia, nella sua etimologia, riassume bene questo concetto, “il dolore del mancato ritorno”. Soffriamo per qualcosa che non ci sarà più. Facciamo uno sforzo di immaginazione adesso. E se questo “qualcosa che non torna”, in realtà, potesse tornare ogni volta che vogliamo, con un paio di clic? Si, per ora torna ogni volta che strisciamo un’American Express Gold, ma sappiamo bene che nel giro di qualche anno esploderà a livello commerciale per tutti. E se, ogni volta che voglio, potessi parlare con l’avatar di mio padre, mia moglie, mio fratello, i miei cari defunti, come se fossero lì con me sul divano? Non posso avere nostalgia di qualcosa che torna a comando, per definizione.
Usciamo dalla cerchia stretta delle interazioni quotidiane, pensiamo a quel cugino che vive lontano, o la nonna che vedo solo a natale perché sta ancora al paesello, o il miglior amico di scuola con cui “ci sentiamo solo più per gli auguri ma non riusciamo mai a organizzare”.. Cosa cambia se domani muoiono? Li sentivo sempre e solo al telefono, se mi rispondono pure da morti, che problema c’è? Che valore ha qualcosa che possiamo avere a disposizione sempre?
Pensiamo al rito funebre, la famosa corrispondenza di amorosi sensi, il semplice gesto fisico di andare al cimitero, o avere un luogo deputato alla celebrazione di chi non c’è più; che senso avrà quando quel luogo deputato starà nella tasca della giacca e potrò portarmelo ovunque? La morte a quel punto sarà un semplice cambio di stato, polvere eri e polvere ritornerai, ma rimani in byte. A disposizione di chi accende o spegne quando vuole sentirti.
Tutto questo ci colpisce nei sentimenti personali, e ognuno ha una propria sensibilità, quindi la tecnologia, come sempre, ci fornisce uno strumento, poi come lo usiamo sono fatti nostri. Ma siccome nessuno di noi è un’isola, a livello collettivo un nuovo rapporto con la morte e con la memoria dovrebbe darci da pensare. Creiamo noi stessi a nostra immagine e somiglianza, e ora creiamo l’iconografia di noi stessi dopo che saremo morti. Ma d’altronde l’abbiamo sempre fatto, tutti e con tutti. Non abbiamo nessuna fotografia di Gesù Cristo, di Giulio Cesare, o Napoleone. L’immagine che ci siamo fatti di loro è una media statistica raccolta tra migliaia di quadri, statue, monete, effigi varie coeve e postume, raccolte nel corso dei secoli. Abbiamo creato a tavolino i loro volti per perpetuarli nel tempo, inciderli nella pietra della memoria, scegliendo la loro immagine come summa dei loro caratteri specifici. Anzi, di quei caratteri specifici che noi gli abbiamo attribuito.
Un po’ come se avessimo preso i loro profili Instagram e fatto un mix di tutte loro fotografie. Buon per loro che non avessero troppe immagini di aperitivi o con la bocca a culo di papera. Idealizziamo la nostra immagine, e quella degli altri, nel passato e nel futuro, da una rappresentazione che è stata, e sarà per sempre, soggettiva, fino a farla diventare collettiva.
Ora facciamo un’iperbole fantascientifica, per semplificare. Nel celeberrimo film di Ridley Scott, Blade Runner, degli esseri sintetici denominati “Replicanti” vivono una vita limitata e artificiale, indistinguibile da quella umana. Per rendere l’interazione con gli umani più “realistica”, i progettisti decidono di gratificare i Replicanti con dei “ricordi artificiali”, per sviluppare in poco tempo “sentimenti e conoscenze che noi umani diamo per scontate”. Putacaso, nel film la rappresentazione di questi ricordi artificiali sono ancora delle fotografie stampate, su carta opaca. (Sono quei meravigliosi paradossi del cinema di fantascienza, per cui si viaggia tra le galassie a velocità luce, ma poi ci si parla col walkie talkie con l’antenna estraibile).
La protagonista femminile del film, Rachael, è un replicante che non sa di essere un replicante. La sua memoria è colma di “ricordi di qualcun’altro”, e questi ricordi sono immagini, letteralmente riversate nel suo cervello bionico, come facciamo noi con una penna usb. Il protagonista Rick Deckard, è un cacciatore di replicanti che a sua volta ha dei ricordi confusi, al limite del reale. Come se glieli avessero infilati da una penna usb. Tutto il film, e molto di più il romanzo da cui è tratto, gioca su questa ambiguità di “cosa sia reale”. La questione è questa: se i ricordi e le memorie ci identificano come esseri umani, nel momento in cui dei ricordi artificiali identificano degli esseri artificiali, cosa ci distingue da loro? E di conseguenza, cosa ci rende “umani”?
Derive fantascientifiche, ma il dato che ci interessa in questa sede è la valenza del ricordo, identificato con le immagini, come strumento per classificare un umano come “vero umano”. E forse è un problema che dovremmo porci, visto che nel “mondo del futuro di Blade Runner” ci siamo dall’altro ieri. E visto che stiamo allenando una tecnologia a ricreare noi stessi guardando i nostri ricordi, insieme ai ricordi di tutti gli altri, e facendo una media statistica. E a questa tecnologia stiamo dando in pasto una narrazione edulcorata a tavolino. Per 100 foto in cui sorridiamo, in spiaggia, col cocktail in mano, gli amici al concerto, il bacio al tramonto, ce ne sarà forse una in cui siamo malati. Non fotografiamo mai il dolore, la malattia, quando siamo depressi, quando la vescica ci molla per strada o quando il lavoro non va come vogliamo. Raccontiamo solo il bello che vogliamo raccontare di noi stessi, anche per un’idea distorta che abbiamo creato, per cui “una foto è più bella se succede qualcosa di bello”.
Diamo in pasto al futuro una rappresentazione di noi stessi arbitraria e soggettiva. Ma decisamente poco realistica. Se ci abituiamo a tutto questo, in futuro ci interesserà sapere come eravamo realmente? Se prima di morire posso decidere che ricordo lasciare di me, muoio davvero? Le implicazioni etiche e legali di questi fenomeni sono infinite, e saranno tema di discussione negli anni a venire. Già sono in produzione film con James Dean redivivo grazie all’AI, mentre in tribunale si discute della possibilità di resuscitare Marylin per qualche nuova commedia. Ammetto che non mi dispiacerebbe neanche sentire un nuovo disco di John Lennon, di Hendrix, o dei Nirvana, magari insieme! Perchè poi è li che si andrà a parare. Una volta aperto il recinto, è difficile far rientrare le app. E se quelli resuscitano David Bowie, io potrò tenermi mio nonno in salotto, o no?
Un giorno i servizi di memoria post mortem saranno la norma, diventeranno facilmente un’abitudine, ma occorre farci i conti con cosa significa per chi vive, e per il nostro rapporto con la mortalità e i ricordi. Il problema dell’informazione, del fact-cheking, del complottismo ci ha dimostrato che le immagini si prestano a tutte le narrazioni che vogliamo dargli, siamo quindi già da tempo di fronte a un problema tangibile e drammaticamente concreto. Nel momento in cui lasciamo entrare l’abitudine all’artificio tra le mura domestiche, forse dovremmo bilanciare con una nuova consapevolezza di noi stessi e del rapporto che abbiamo con la nostra immagine, e tutto ciò che essa comporta. Perché come la storia ci insegna, riscrivere il passato inevitabilmente compromette il presente.
Di fatto ci viene concessa una sorta di immortalità, per chi muore e per chi resta, e siamo invitati a riflettere che abbiamo una responsabilità anche quando diventiamo ricordi. Torniamo al racconto con cui abbiamo iniziato: il momento chiave in cui, da che si fotografavano i Re o i potenti, abbiamo cominciato a fotografare la persona qualunque per strada, e quella è diventata il racconto per immagini delle genti del Mondo.
Prima erano tutti baffoni impettiti e signore austere, adesso ridiamo tantissimo. Prima potevano permetterselo in pochi, ora è alla portata di tutti. Prima creavamo le nostre memorie facendo le cose, ora possiamo crearle senza muoverci dalla sedia e farle a nostro piacimento, come scegliere gli ingredienti di una pizza. Sono dinamiche sempre molto simili, e cicliche; ma ad ogni giro di ruota si mette in gioco qualcosa di nuovo. Guadagniamo questo, perdiamo quello. Non ci sono risposte facili o soluzioni universali, ma potremmo iniziare ponendoci le domande giuste, e cioè quale rapporto vogliamo avere con queste tecnologie? Cosa siamo disposti a sacrificare, o cosa vogliamo conservare rispetto alla nostra memoria, intima e collettiva?
E improvvisamente, poco più di un secolo dopo, succede ancora che qualcuno si rimette sul divano a guardare vecchie fotografie, per scegliere quelle col vestito buono, andare in uno studio, spendere dei soldi, e creare un ricordo che riporteremo a casa, in un posto ben visibile del salotto, dove potremo riviverlo ogni volta che vogliamo, con un clic.