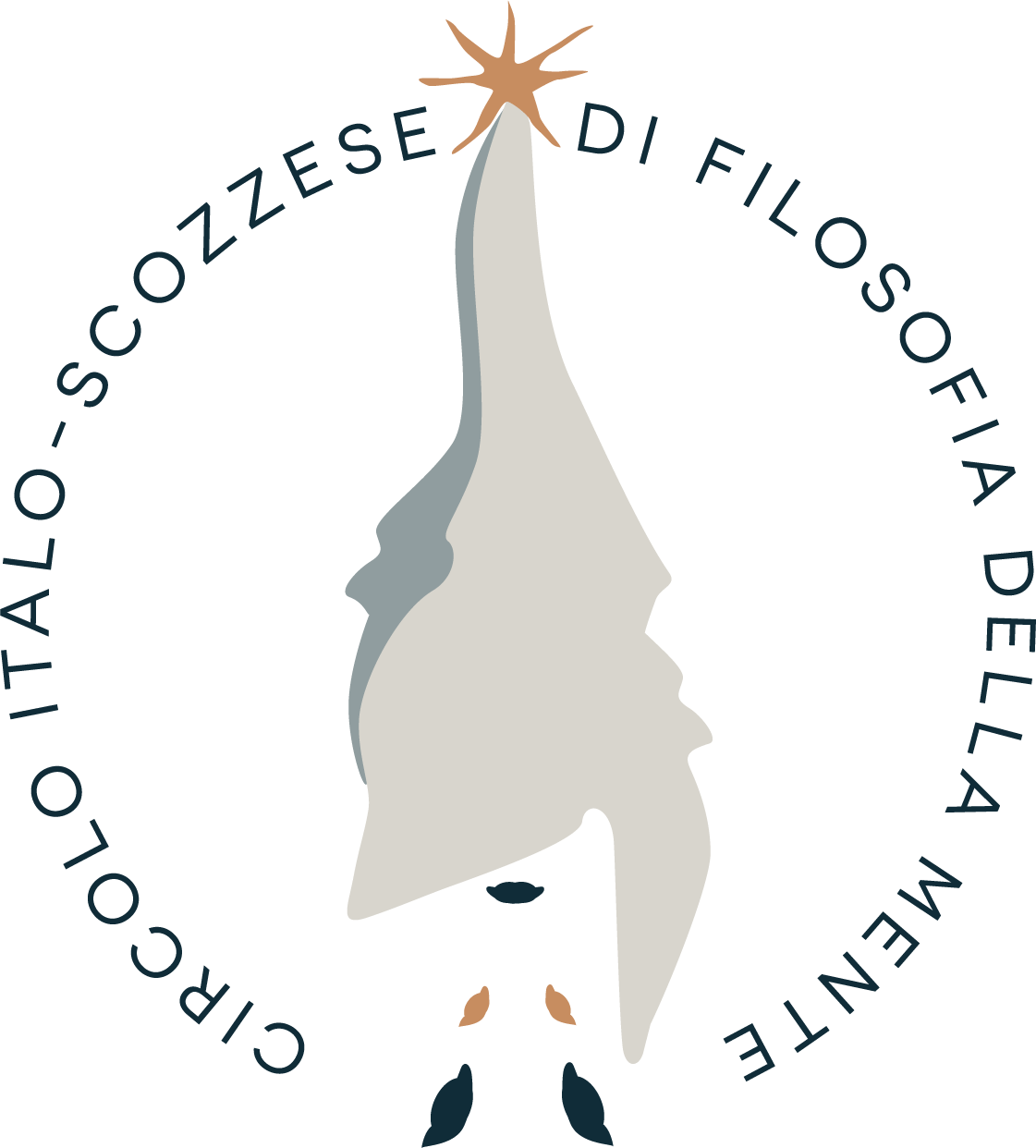Note a margine su un passo di David Hume

In un passo del Trattato sulla Natura Umana, Hume propone una celebre analogia tra la mente e il teatro, concludendo però che ci sono ignoti sia il luogo in cui queste scene si verificano, sia i materiali, gli elementi ultimi che le costituiscono. Detto altrimenti, si tratta di un teatro interiore di cui ci sfugge quasi tutto l’essenziale. A partire da queste poche ispirate righe, come anche da un passaggio dell’indimenticabile Because the Night della poetessa del rock Patti Smith, è possibile ricavare un certo numero di osservazioni sulla natura della mente e, in fin dei conti, della verità.
di Leslie Cameron-Curry
Come on now try and understand
The way I feel when I’m in your hands.
Patti Smith, Because the Night, 1980

Patti Smith
Possiamo immaginare un pipistrello modulare con ultrasuoni l’esortazione “Prova a capire come mi sento quando sono nelle tue mani”, magari nel momento in cui un essere umano lo ha afferrato con forza e si appresta a tagliare dei fili di plastica che lo intrappolano impedendogli di volare?
Certamente molti lettori sanno che questi versi appartengono a una canzone cantata dalla “poetessa del rock” e nessuno, o pochi, ha mai dubitato che non si trattasse di una canzone d’amore e desiderio. Ma ciò su cui vorrei soffermarmi è altro: la richiesta di comprensione che passa attraverso il corpo e le metafore grazie alla quale tale comprensione sia rilevabile. Per fare ciò mi riferirò ad alcune riflessioni sull’arte, a delle opere d’arte, alla concezione di Hume della coscienza e dell’Io e ad alcune conoscenze sul cervello.
Questo breve scritto si concentra sull’analogia fra coscienza e teatro considerando se e come alcune condizioni generali dell’evento teatrale (spazio, corpo e linguaggio) siano adeguate a raffigurare la coscienza. Lo sviluppo del discorso ruota attorno a un’affermazione di Hume sull’effettiva adeguatezza della corrispondenza fra spazio teatrale e coscienza per cui giungo a una conclusione scettica sulla validità di tale analogia. Infatti, paiono altre le condizioni adeguate a parlare della coscienza: da un lato il corpo, in quanto reticolo inter – relazionale e bio – fisiologico che coinvolge me e gli altri, io e i personaggi della coscienza; dall’altro il linguaggio come veicolo di verità in relazione semantica con il corpo. A questo proposito, riprendo un’osservazione di Shakespeare sul lavoro dell’attore che deve evitare eccessi, semplificare e ridurre piuttosto che amplificare ed esagerare. Queste indicazioni si rivelano particolarmente illuminanti in quanto vicine da un lato ai processi nervosi e cerebrali di attivazione dei moduli percettivi; dell’altro alla concezione della verità come compressione, che sembra spiegare alcune dinamiche della coscienza. In alcuni punti mi diverto a proporre degli esperimenti linguistici per evidenziare alcuni limiti delle metafore usate per parlare della coscienza.
LA MENTE PER HUME

David Hume
Nel Trattato sulla natura umana Hume scrive alcune osservazioni sulla mente che riporto di seguito.
La mente è una specie di teatro, dove le diverse percezioni fanno le loro apparizioni, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un’infinita varietà di atteggiamenti e di situazioni. Né c’è, propriamente, in essa nessuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi differenti, qualunque sia l’inclinazione naturale che abbiamo ad immaginare quella semplicità e identità. E non si fraintenda il paragone del teatro: a costituire la mente non c’è altro che le percezioni successive: noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate, o del materiale di cui è composta.
[D. Hume, Trattato sulla natura umana, libro I, parte IV, sez. VI, in Opere filosofiche, pp. 265]
Le percezioni, ovvero il costituente della mente, appaiono come dei personaggi sul palco ma non semplici e neanche identiche a sé stesse nel variare del tempo e neanche la mente è semplice o identica a sé stessa in quanto è comparsa e scomparsa di percezioni. Poi Hume avverte di non volere insistere troppo sull’analogia con il teatro: non sappiamo dove queste scene vengano rappresentate o il materiale di cui sono composte.
La riflessione si fa complessa e sfidante. Da un lato sembra un’affermazione sull’immaterialità della mente – sostanza non estesa – dall’altro l’analogia con il teatro merita delle riflessioni, anche confrontandola con la distinzione operata da Solms e Turnbull sulle due modalità percettive della vita della coscienza: una quella del mondo interiore, l’altra la descrizione scientifica dei processi cerebrali [Mark Solms, Oliver Turnbull, Il cervello e il mondo interno, Raffaello Cortina, Milano, 2004, pag. 64 e sgg.]
IL TEATRO DELLA MENTE
 A titolo personale, ritengo che il teatro sia stato uno dei progetti visionari più audaci e vertiginosi dei greci: allestire uno spazio dedicato all’esibizione di passioni e pensieri umani e così mostrare l’ordine necessario del destino; inscenare l’ordine invisibile immanente al caos della vita in modo da suscitare pietà, terrore e purificare l’anima. Decisamente ambizioso. Sembra, però, che per maneggiare questo materiale irrazionale e brutale occorra soddisfare una condizione: chiarire senza equivoci che di finzione si tratta, che è la rappresentazione di una storia nota, con eroi noti, che si svolge sopra un palco, fra delle quinte di legno e pietra, con attori mascherati e di fronte a un pubblico, riunito secondo riti sociali ben definiti [Jaqueline da Romilly, La tragedia greca, Il Mulino, Bologna, 1996]. Senza questa netta e chiara separazione fra scena e platea, fra attori e spettatori ovvero fra la realtà e la sua imitazione neanche la catarsi è possibile, poiché, come dichiara Aristotele “quelle cose che ci fanno soffrire quando le vediamo nella realtà, ci recano piacere se le osserviamo in immagini che siano il più possibile fedeli, come i disegni delle bestie più sordide o dei cadaveri.” [Aristotele, Dell’arte Poetica, 4, 1 – 2. Traduzione di Carlo Gallavotti, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, Milano, 1997].
A titolo personale, ritengo che il teatro sia stato uno dei progetti visionari più audaci e vertiginosi dei greci: allestire uno spazio dedicato all’esibizione di passioni e pensieri umani e così mostrare l’ordine necessario del destino; inscenare l’ordine invisibile immanente al caos della vita in modo da suscitare pietà, terrore e purificare l’anima. Decisamente ambizioso. Sembra, però, che per maneggiare questo materiale irrazionale e brutale occorra soddisfare una condizione: chiarire senza equivoci che di finzione si tratta, che è la rappresentazione di una storia nota, con eroi noti, che si svolge sopra un palco, fra delle quinte di legno e pietra, con attori mascherati e di fronte a un pubblico, riunito secondo riti sociali ben definiti [Jaqueline da Romilly, La tragedia greca, Il Mulino, Bologna, 1996]. Senza questa netta e chiara separazione fra scena e platea, fra attori e spettatori ovvero fra la realtà e la sua imitazione neanche la catarsi è possibile, poiché, come dichiara Aristotele “quelle cose che ci fanno soffrire quando le vediamo nella realtà, ci recano piacere se le osserviamo in immagini che siano il più possibile fedeli, come i disegni delle bestie più sordide o dei cadaveri.” [Aristotele, Dell’arte Poetica, 4, 1 – 2. Traduzione di Carlo Gallavotti, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, Milano, 1997].
Con il teatro i greci, inoltre, hanno inventato il riconoscimento dei personaggi nei capovolgimenti tragici. Come nota Ricoeur: “Se c’è una cosa che Edipo a Colono dimostra, questa è che il personaggio tragico, per quanto oppresso dal sentimento del carattere irresistibile delle forze soprannaturali che governano i destini umani, resta l’autore di quell’intima azione che consiste nel valutare i propri atti, singolarmente e in una condizione di retrospettiva.” [P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano, 2005, pag. 94]. È lo stesso Edipo che ha ucciso il padre, che ha sposato la madre con cui ha avuto quattro figli, che si acceca, che vaga ramingo accudito da Antigone e che infine muore nel bosco sacro alle Eumenidi a Colono. Insomma, il teatro parla anche di continuità dell’individuo con la quale ci rappresentiamo sia nello spazio pubblico sia in quello intimo. Il teatro sarà anche scatenamento dionisiaco ma il teatro non si improvvisa. E non è caotico. Per rappresentare l’uomo, follia e metodo devono coniugarsi.
Ma cosa resta del teatro interiore dopo l’affermazione di Hume: “non abbiamo la più lontana nozione di dove queste scene vengono rappresentate o il materiale di cui è composta”?
L’ignoranza sul luogo dello spettacolo interno alla mente priva il mondo interiore di una condizione necessaria del teatro. Se, mancando un’area definita che sancisca la differenza fra azione teatrale e pubblico, ovvero fra finzione e realtà, ciò cui assistiamo non è uno spettacolo teatrale, allora nella mente non ci sono rappresentazioni della realtà e la catarsi è impossibile. Voglio sottolineare che la nostra ignoranza non riguarda tanto l’interiorità soggettiva e privata ma l’esistenza di un luogo, uno spazio, da cui assistere agli eventi della scena interiore. Una domanda: dove si trovano palco e platea nel teatro interiore, dal momento che non esiste uno spazio, ovvero un punto di vista definito da cui guardare lo spettacolo della mente? Lo spettatore è la commedia e la commedia è lo spettatore ma non come uno specchio pulito poiché le intenzioni dello spettatore, le sue dinamiche fatte di passaggi, ritorni, ossessioni lo rendono spettatore, regista e attore allo stesso tempo di uno spettacolo di cui è coautore, forse consapevole.
L’ignoranza sul luogo, inoltre, rende indistinguibili le quinte, lo sfondo, il proscenio e tutto ciò che definisce il palco come luogo della “azione scenica” fatta di effetti di realtà, illusioni prospettiche, di accessi da cui gli attori appaiono e scompaiono secondo una regia che dà ordine allo spettacolo. Riferendo alla mente la cancellazione di tutto ciò, si può dubitare della sovradeterminazione della coscienza: come non c’è un regista nascosto dietro e prima delle quinte che guida le entrate e le uscite di scena degli attori, così le esperienze e la mente non sono governate da un principio, un “Io penso” o uno Spirito che organizza, o fornisce i contenuti dell’esperienza. Le sensazioni fluiscono liberamente, senza controllo e il loro sfociare in configurazioni non porta il segno dell’Io o dello Spirito. Un fascio intricato senza priorità, subordinazioni, dipendenze e condizioni.
La cosa non va meglio quando cerchiamo di capire i personaggi della coscienza: impressioni che appaiono e scompaiono velocemente componendo configurazioni a cadenza variabile. Non sostanze immutabili e neanche sensazioni atomiche semplici che sottodeterminano la coscienza ma un “flusso” che scorre in un luogo senza luogo, visto da uno sguardo privo di un punto di vista. Del resto, già in queste poche pagine inciampiamo su un ostacolo linguistico arduo da superare, in quanto i termini che usiamo contengono sempre metafore spaziali: scorrere, fluire, punto di vista, sovra e sotto determinazione, fuori, dentro. Siamo in quella condizione di indicibilità della mente che Peter Godfrey – Smith cerca di descrivere come rumore di fondo, rumore bianco all’origine della coscienza? [P. Godfrey – Smith, Altre menti, Adelphi – Animalia, Milano 2018, pag. 103].
Credo che convenga farsi coraggio e rivedere uno dei presupposti della nostra concezione dello spazio, e soprattutto di quello interiore, per lasciar cadere l’idea che gli elementi primitivi di cui è fatto lo spazio della mente siano come i punti da cui si costruiscono forme e volumi. E se i punti fossero l’esito di un processo astrattivo per cui assegnare alla mente un “punto” di vista sia un errore di concretezza malposta, con cui si attribuisce esistenza concreta all’astrazione che semplifica l’aggregato polimorfo di partenza? E se lo spazio della mente non fosse composto da punti, rette, piani con tutti i trompe l’œil della finzione scenica, ma da continuità, sovrapposizioni, estensioni polimorfiche, bordi e toroidi, luoghi iperbolici e parabolici? Il palco della mente non sarebbe costruito da assi orizzontali, ortogonali con prospettive per ingannare il pubblico e sopraelevato rispetto alla platea, ma estensioni slabbrate, continuità avviluppate su sé stesse e lacerti distesi. Con un certo estro poetico, si potrebbe sostituire l’espressione “punto di vista” con “bordo di vista”, “campo di vista”, o, meglio ancora, “straripamento con vista”, ovvero estensione frastagliata, rischiosa e sfumata dell’aggregato multiforme delle sensazioni ed emozioni. Ma come vedremo anche la “vista” deve essere nominata diversamente.
Ma torniamo al canto iniziale e al suo ritmo. Cosa comprendo quando le mani dell’altro mi toccano? E cosa posso rispondere quando l’altro mi chiede comprensione? Come risuonano nei nostri corpi le mani che ci toccano e le domande che suscitano? Come la speranza e la richiesta di un incontro scambievole fra mani e parole possono essere soddisfatte e non risuonano come campane a morto fra le pieghe della nostra mente? Potremmo descrivere ciò che accade quando ci tocchiamo come la generazione di un campo scenico interiore intersoggettivo e non più come una recita interna, privata?
BLIND DATE CON LA MENTE
La difficoltà di parlare di spazi della coscienza, della mente sembra rendere impossibile dire qualcosa sulla coscienza. Infatti, ignorare se esista un luogo del teatro, significa anche misconoscere dove e quando si tenga lo spettacolo. Nel mondo – euclideo? – è possibile darsi appuntamenti in luoghi precisi per assistere a spettacoli compiuti; due persone, per esempio, potrebbero inscenare un litigio in pubblico, per una candid camera o flash mob, ma gli attori resterebbero senza spettatori e gli spettatori senza spettacolo se a un certo momento non si svelasse che in quel luogo a quella ora si è tenuta una recita. Ma, esistono appuntamenti certi con la mente, dal momento che alcuni – molti – spettacoli si tengono in “allagamenti emozionali” di cui ignoriamo l’esistenza? Il flusso della coscienza, ribadisco, non va considerata ingenuamente come un fiume che scorre con verso e direzioni univoci, come se la nascita fosse la fonte della mente collocata in alto su di un monte e la storia successiva fosse lo scendere dell’acqua attratta dalla gravità verso il proprio destino marino. Nelle stesse parole di Hume le percezioni passano e ripassano. Ma non solo. L’apoteosi moderna dello stream of consciousness, l’Ulisse di Joyce, mostra di ciascun personaggio ritorni, ingorghi, momenti di stagnazione, direzioni discordanti. Infine, gli studi sui traumi e le loro conseguenze nel fisico dei traumatizzati, dimostrano che la coscienza alle volte non fluisce proprio per nulla lasciando il traumatizzato in una coazione a ripetere senza tempo e senza mente. [Vedere Bessel Van Der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Cortina, Milano, 2015].
Il trauma che ci imprigiona è frutto di uno straripamento chimico che distrugge qualsiasi modalità di contenimento e di rielaborazione: le persone traumatizzate restano imbozzolate nelle visioni eterne e assolute di dolore.
Ma, se non sappiamo dove si trovi il teatro, quale siano i personaggi e quale la trama, dove si trovi la platea e dove il palco, in che senso ci parliamo e comprendiamo? Dove ci diamo l’appuntamento della comprensione? Credo che ci comprendiamo molto più spesso di quanto crediamo o sappiamo perché toccare, anche senza pensarci, la mano tesa verso di noi è già la dichiarazione chiara di aver capito. La comprensione è fatta di appuntamenti irripetibili che non hanno sempre il sigillo della consapevolezza, dell’intenzionalità cristallina. Più vicine al cuore degli esseri umani sono le parole dette senza troppo pensare, il gesto inaspettato ma avvenuto al tempo opportuno. Sorprendendoci. Come se sapessimo senza sapere.
Ora, noi sappiamo che le sensazioni, di cui la mente è fatta, affondano le loro radici nel corpo, nelle azioni e reazioni sinaptiche, biochimiche del cervello, a loro volta nodi di un reticolo biofisico che si articola ben oltre queste braccia e questo cervello fino a lambire ogni bioma dell’universo. Ma non vorrei balzare troppo rapidamente in una facile visione totalizzante dell’universo, che così pensato sarebbe minore della somma delle sue parti poiché ci sono biomi ignoti e paesaggi oscuri che rendono problematica la continuità reale. Questo salto, inoltre, non ci dice nulla di quello che proviamo quando siamo nelle mani di quella persona, l’unica da cui speriamo una risposta.
Meglio fare un passo indietro e recuperare alcune cose e metterle a confronto con scoperte e modelli di descrizione della mente.
MODULI FISICI, TEATRALI E RITMI
L’analogia fra mente e teatro fino a ora ha mostrato che ignorando il luogo della mente, nel teatro interiore vengono a mancare le condizioni della rappresentazione. Ma c’è altro nel teatro: il corpo e il linguaggio.
Corpo e linguaggio nel teatro non sono disgiunti. Il testo teatrale da solo è una voce fantasmatica assetata di vita come lo spettro del padre di Amleto che chiede vendetta per il suo assassinio. Il corpo senza un testo è privo di storia. Procediamo con ordine per trovare possibili modi per parlare della coscienza.
Il corpo
Se consideriamo la presenza dei corpi in uno spettacolo teatrale, possiamo definire l’opera teatrale una specie di adattamento evolutivo reciproco degli organismi coinvolti. Qualunque attore sa che nessuna replica dello stesso testo è identica alle precedenti. Qualunque bravo attore sa che le intonazioni, le pause, i gesti variano ogni sera poiché “sentono” che quella intonazione, quella pausa erano adatte a quel momento quella sera. Qualunque bravo attore si fida del suo corpo, che sente cose di cui la mente non è consapevole. Il pubblico, reciprocamente, reagisce fisicamente agli attori. Considerando l’intreccio di scambi, reazioni, retroazioni e attivazioni neuronali e sinaptiche, lo spettacolo appare l’esito evolutivo delle interazioni fisiologiche e biochimiche di attori e pubblico che si scoprono e si nascondono reciprocamente. La stretta relazione fra corpo e opera d’arte, del resto, è ricorrente in tutte le attività artistiche, per esempio nel differente modo di suonare gli strumenti nella musica classica, nel jazz o nel rock [John A. Sloboda, La mente musicale, il Mulino, Milano, 1998; per l’improvvisazione Jazz vedere capitolo “Composizione e improvvisazione” e in particolare pag. 233]; poi abbiamo l’esperienza del dripping di Pollock che metteva in scena un vero e proprio balletto quando sgocciolava le tinte sulla tela distesa per terra; abbiamo anche varie modalità di scrittura che vanno dall’immersione nella vasca da bagno alla scrittura seduti in bar rumorosi.
Nello spettacolo teatrale attori e spettatori incarnano “sistemi di comando delle emozioni di base” radicati nelle aree più antiche del cervello umano che presiedono alla comunicazione delle emozioni, piacere, rabbia e così via. La maggioranza di questi agisce inconsciamente senza che i moduli collegati alla consapevolezza della percezione si attivino [Cfr. Solms, Turnbull, op. cit., pag. 86], per cui il nostro corpo sa più di quello che siamo coscienti di sapere. In alcuni casi, si schiude un varco evolutivo nella mente dei coautori dell’opera teatrale. Il fascio di stimoli viene compresso in un pensiero diventando consapevolezza formulabile a parole. Le possibilità relazionali comuni dei moduli emotivi diventano possibilità mentali in quella specie di ambiente aperto che è la mente.
Il testo teatrale
Il testo teatrale è un pretesto cui occorre dare corpo e voce. Tuttavia, il testo teatrale, anche nella sua incorporeità, è fatto di ritmi e cadenze. Una stessa frase può diventare comica o tragica cambiandole il ritmo e l’accento. A titolo d’esempio si può recitare la battuta teatrale più famosa – “Essere o non essere, questo è il problema” – con ritmi e pause differenti per sperimentare la flessibilità del testo. In alcuni casi suscita ilarità, in altri commozione.[È possibile visualizzare sul web un esempio di questo esperimento che vede coinvolti attori di lingua inglese (Paapa Essiedu, Tim Minchin, Benedict Cumberbatch, David Tennant, Rory Kinnear, Sir Ian McKellen, Dame Judi Dench) che recitano il verso “To be or not to be, that is the question” con diverse pause e ritmi aprendo ciascuno una possibilità interpretativa nuova. Il filmato, del 2016, si conclude con l’intervento del futuro Carlo III che sembra chiudere con la parola definitiva, credo con ironia britannica. (https://youtu.be/RJXiep-yGBw?si=EMMy8Nqqc6PhT_fU)]
A questo proposito è essenziale citare Shakespeare, che si fa beffe di qualsiasi unità di tempo, luogo e identità e non esita a guardare nel battito irregolare del cuore umano che sconfina oltre il limite della follia con meravigliose facilità e ingenuità. Cosa ci dice Shakespeare, così consapevole del rapporto fra teatro e mente da far dire ad Amleto di potere accertare la colpevolezza del patrigno, facendolo assistere a degli attori girovaghi che inscenano un assassinio simile a quello del padre ordinata dal patrigno stesso?
Il teatro catturerà la coscienza del re, esclama Amleto, ma con una proposta di verità teatrale, e di coscienza, diversa da quella di Aristotele. Attraverso Amleto, Shakespeare ci dice qualcosa frutto della sua esperienza di scrittore e uomo di teatro: nel teatro l’esagerazione genera un effetto di falsità quasi imbarazzante; gli attori non devono esagerare nei gesti e nelle parole credendo che questo dia voce alla verità, la quale, invece, chiede misura e contenimento. Nulla di troppo perché la verità ha una sua misura. Interessante al proposito è un’analogia, formulata da Estelle Parsons nel film di Al Pacino, Riccardo III – Un uomo, un re (Looking for Richard, 1996), fra il ritmo del pentametro giambico delle opere di Shakespeare e il profilo del formichiere con la sua grossa schiena tonda che termina con una lunga e sottile lingua cha scava nel fondo della terra per cacciare le formiche [Il pentametro è composto da cinque “piedi” (metri), e il giambo è un piede composto da una sillaba atona (non accentata, breve, che “sale”) seguita da una sillaba tonica (accentata, lunga, che “scende”). Come il formichiere si estende in profondità per attingere al formicaio con il suo muso allungato e la lingua, così la parola teatrale deve “attingere” in profondità, nelle motivazioni, nel significato e nell’emozione ovvero nel corpo aggiungiamo noi, per pronunciare le parole in modo corretto. Il ritmo è profondamente legato al significato psicologico e all’emozione della battuta. L’attore non deve solo recitare, ma deve trovare la “profondità” emotiva nascosta nel ritmo del pentametro giambico fatto di una “prima parte che sale”, come la gobba del formichiere e di una “seconda che scende”, come il suo muso. L’attore sprofonda nel corpo di cui esplora le ferite e le gioie segrete e poi riemerge con un tesoro di dolore e godimento sotto forma di parole modellate nel ritmo della frase, detta all’unisono con il cuore umano [L’analogia con il formichiere trova delle corrispondenze con delle analisi di Harold Bloom, Shakespeare. L’invenzione dell’uomo, sul ritmo del verso].
Il ritmo del testo è la forma che rende possibile la verità, la mente.
MENTE E SEMPLIFICAZIONE
Come tenere assieme tutte queste riflessioni che sembrano divergere o provenire da contesti incommensurabilmente distanti?
Negli ultimi anni è emersa la definizione della verità come compressione. Di derivazione informatica questa concezione mette al centro della riflessione il principio di Minima Lunghezza di Descrizione (MDL). Questa teoria, che riprende il “rasoio di Occam”, suggerisce che la migliore spiegazione per un insieme di dati, e quindi quella che è più “vicina alla verità”, è quella che fornisce la descrizione più breve e concisa dei dati stessi. Avvicinarsi alla verità non significa enumerare passo per passo un evento ma individuare la funzione immanente che lo governa. La compressione richiede di catturare la regolarità, scartando il rumore e così di descrivere una grande quantità di dati con pochissime informazioni, per esempio, la legge di gravità di Newton descrive il moto di milioni di oggetti con una formula concisa.
E se il nostro teatro interiore non fosse propriamente spaziale perché è compressione del flusso di stimoli biochimici che arrivano dal corpo? Il cervello è un complesso sistema di soglie sinaptiche, di selezione di stimoli, di instradamenti che riducono i dati ridondanti. A controprova abbiamo le esperienze traumatiche che, alterando l’equilibrio fra sistema simpatico e parasimpatico, producono un’esplosione incontrollata di adrenalina nel corpo delle persone distruggendo difese riflessive, processi cognitivi e imprigionando la persona negli spazi angusti del trauma. La vita della mente è semplificazione, compressione dinamica e fluida che procede per tentativi ed errori, per immersioni nel corpo e di compressione degli stimoli, in un libero gioco di formazione e deformazione. L’effetto spaziale primo piano/sfondo sarebbe l’effetto di come la “compressione” ha luogo: con o senza perdita di dati; con l’applicazione rigida di schemi relazionali appartenenti a differenti configurazioni della coscienza; con il necessario “spacchettamento dei dati compressi” o con la scoperta della loro perdita irreversibile. Tutto ciò è possibile in ciclo di “immersione nella”, ed “emersione dalla” sapienza del corpo. Tramutati in formichieri giambici, apriamo la semantica, che per un gioco di parole potremmo chiamare “somantica”, in quanto il significato del linguaggio si trova nella relazione con il corpo. A questo proposito, vorrei leggere l’esordio di Amleto, le parole con cui esordisce nel primo vero monologo dell’opera.
Ah, se questa mia troppo, troppo solida
carne, potesse sciogliersi in rugiada!
Il monologo prosegue con invettive contro Dio che vieta il suicidio, affermazioni misogine sulle donne e altre cose molto amletiche e adolescenziali. Tuttavia, in quell’ottativo iniziale, si potesse sciogliere il corpo solido in rugiada, risuonano stream of consciousness ancora da venire e da sperimentare: rendersi fluidi, ovvero perdere identità e sciogliere i confini fra vita e morte, fra corpo e mente, fra io e tu. Ritroviamo qui la scomparsa delle quinte dal teatro della mente anticipata da Hume. Pensieri e corpo fluiscono, senza identità predeterminata e si illuminano a vicenda in un continuo processo di semplificazione, conservazione, perdita e recupero dei dati, ovvero delle esperienze e delle emozioni.
MA HAI CAPITO COME MI SENTO?
Torniamo all’inizio e alla poetessa del rock fra le mani del suo amante, che ai tempi era lontano da lei. L’amante avrà capito cosa significava per lei quell’abbraccio? Forse sì. Mi piace immaginare che per un attimo la sapienza non spaziale dei loro corpi sia stata così intensa da annullare la distanza che li separava. Per un attimo hanno danzato al ritmo delle loro menti corporee sorridendosi e giocando il gioco seduttivo del mostrarsi nascondendosi. Per una volta irripetibile, si sono scambiati delle parole impresse nei loro nervi vibranti che da allora sono trasformati per sempre.
Non sappiamo se è accaduto di nuovo o se quell’istante duri ancora oggi.