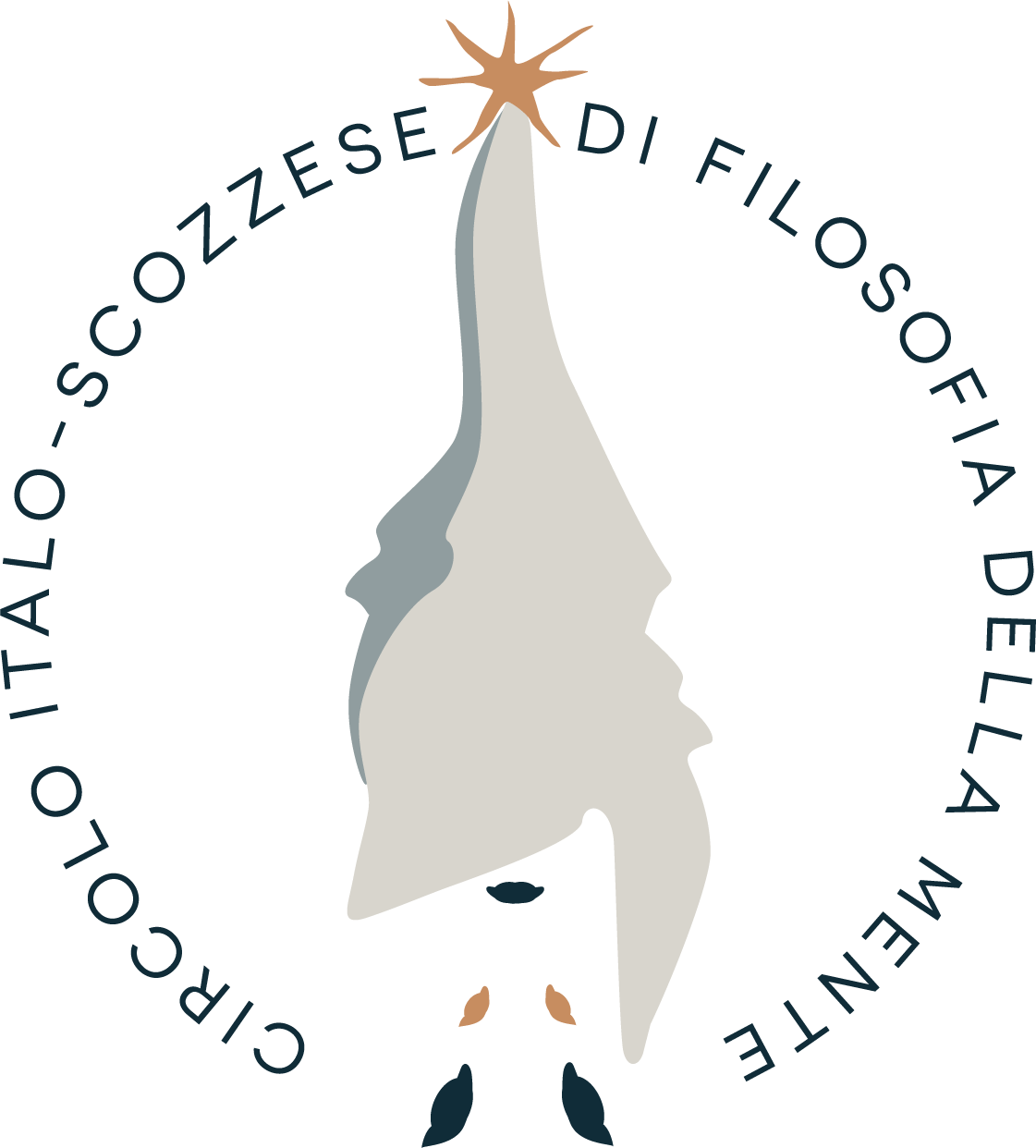Perché un circolo di filosofia della mente? Ce n’era davvero bisogno?
Tra le cose cui noi esseri umani teniamo di più – oltre a mangiare, dormire, riprodurci, attraversare i mari e scalare le montagne – c’è anche il farsi un’idea su com’è fatto e come funziona il mondo in cui viviamo. Più tecnicamente, potremmo dire che nonostante le apparenze svagate ci impegniamo parecchio per edificare una qualche personale ‘visione del mondo’, possibilmente dotata di senso. Alcuni tra noi sembrano avere addirittura un’ossessione per queste ‘visioni del mondo’, lavorano incessantemente per generarne di migliori, più sofisticate, più esplicative, più aderenti allo stato delle cose, e di solito sono detti, o amano auto-definirsi, ‘filosofi’. In questo senso i filosofi sarebbero quindi tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo di visioni del mondo sempre più significative e utili a orientarsi nel variegato regno delle ‘diecimila cose’, come lo chiamavano i taoisti.
Ne consegue che non sono filosofi solo quelli che insegnano filosofia nelle accademie, ma tutti coloro che si pongono delle domande sul mondo in cui vivono e si adoperano seriamente per formulare delle risposte o, come spesso accade, per riformulare le stesse domande in modo più pregnante. In questo senso sono filosofi anche i fisici, i matematici, gli antropologi, gli etologi, i neurofisiologi e insomma gli scienziati in genere, come anche molti uomini impegnati in attività apparentemente distantissime. È difficile sostenere, ad esempio, che il tabaccaio di Nuova Delhi Nisargadatta Maharaj, non fosse un filosofo – e che filosofo! – in questo senso. La filosofia sembra quindi essere, sin dall’origine, assolutamente interdisciplinare e aperta a tutti.
Purtroppo, come sappiamo, le ‘visioni del mondo’ sono strutture concettuali infide e piene di trabocchetti; a volte si tratta addirittura di vere e proprio cosmologie, con tutte le complicazioni dottrinarie e religiose che ne conseguono. Averci a che fare non è facile, servono menti disinibite e disposte a reggere con disinvoltura il doloroso travaglio del dubbio sistematico. Tra i punti critici di ogni visione del mondo, forse il più critico di tutti è lo scivolosissimo ed iper-semico concetto di ‘mente’. Che ruolo ha la mente nella nostra visione del mondo? Dove la mettiamo, che cos’è esattamente? In un certo senso sappiamo tutti di cosa parliamo quando parliamo della mente, ma quando si tratta non tanto di definirla ma almeno di circoscriverla nell’ambito di una struttura concettuale maneggevole, l’asino casca sempre per terra. Sia che ci diciamo dualisti, monisti, o dual aspects monist, o qualsiasi altra cosa, il ruolo della mente resta in cima alle nostra preoccupazioni, per validissimi motivi. Si potrebbe anche dire, senza andare troppo lontano dal vero, cha la filosofia della mente è il nucleo ribollente di qualsivoglia visione del mondo, paradossalmente anche di quelle che sostengono la non esistenza della mente.
Le domande tipiche della filosofia della mente sono tra le più ardue e decisive della filosofia tutta. C’è il problema mente-corpo: qual è la relazione tra stati mentali (pensieri, emozioni, sensazioni) e stati fisici del sistema nervoso centrale? Come possono fenomeni apparentemente immateriali emergere da processi neurologici fisici? C’è anche la questione scottante della coscienza: cos’è esattamente? Quali sono i requisiti ineludibili affinché si manifesti l’esperienza soggettiva e qualitativa (i cosiddetti ‘qualia’)? Perché abbiamo esperienze coscienti invece di essere semplicemente degli ‘zombie filosofici’ che reagiscono agli stimoli meccanicamente, senza alcuna consapevolezza? Collegate a questa ci sono altre celebri questioni, come quelli dell’intenzionalità (come fanno i nostri stati mentali ad essere ‘diretti verso’ qualcosa o essere prodotti ‘a proposito di’ qualcosa?) dell’identità personale (cosa rende una persona la stessa nel tempo nonostante i cambiamenti fisici e psicologici? Qual è il ruolo della memoria e della continuità psicologica?) o del libero arbitrio (le nostre azioni sono davvero libere o sono determinate da cause pre-esistenti? Come si concilia la libertà di scelta con il determinismo delle leggi fisiche?). Per non parlare di tutti gli interrogativi legati all’uso filosofico o ordinario del linguaggio naturale e degli altri sistemi simbolici, croce e delizia dei pensatori di ogni epoca.
Ecco, il linguaggio. Per decenni in Italia la filosofia di matrice anglosassone è coincisa con la filosofia del linguaggio, traendo la sua linfa dalle riflessioni trasversali del primo e secondo Wittgenstein. Di filosofia della mente in senso stretto non si occupava quasi nessuno, di Fodor, Dennett o Chalmers si parlava pochissimo. Poi qualcosa è cambiato. Come ha detto Diego Marconi in una sua recente conferenza, da alcuni anni a questa parte la filosofia ha smesso di considerare il linguaggio l’unica porta di accesso, l’unico oggetto legittimo della riflessione filosofica, e si è verificato un brusco ‘ritorno alle cose’, addirittura un ritorno alla metafisica. Inoltre, lo sviluppo prepotente delle neuroscienze, delle scienze cognitive, dell intelligenza artificiale e della robotica, ma anche dell’etologia, antropologia, sociobiologia, eccetera, ha riportato le tipiche domande della filosofia della mente al centro del dibattito. Tutto questi sviluppi si sono manifestati a livello planetario, ma come al solito in virtù del nostro caratteristico retaggio culturale, l’Italia è rimasta un po’ nelle retrovie.
Ecco perché ci è parsa insopprimibile l’esigenza di dar vita a un Circolo Italo-Scozzese di Filosofia della Mente a Torino. Qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi perché mai ‘italo-scozzese’. Innanzitutto perché uno dei fondatori ha origini scozzesi, e già sarebbe un motivo sufficiente. Ma poi anche perché la Scozia ha dato i natali a pensatori del calibro di David Hume, Thomas Reid e Sir William Hamilton, che con il loro approccio empirista e l’attenzione per i fenomeni mentali hanno gettato le basi speculative della riflessione filosofica sulla mente. Infine, last but not least, perché suona bene e la bellezza vuole la sua parte.
Il logo del Circolo, infine, è opera dell’artista multimaterica Giorgia Scioratto e rappresenta un pipistrello stilizzato in ossequio a uno dei paper più celebri di tutta la filosofia della mente, What is it Like to Be a Bat, di Thomas Nagel. Nell’immagine ci sono altri riferimenti importanti, ma vi lasciamo il piacere di scoprirli da soli.
Il Circolo non ha alcuna finalità commerciale, reputazionale o di carriera. Ai membri è solo richiesto di condividere il proprio sapere, le proprie convinzioni e perplessità con tutti gli altri, e soprattutto di divertirsi nel corso degli incontri, sempre bene organizzati (non amiamo perdere tempo) ma assai poco formali. Ognuno è libero di andare e venire quando gli pare, basta che non faccia troppo rumore e non generi eccessivo rimpianto. La partecipazione al Circolo è su invito, ma esortiamo tutti i veri pensatori bene intenzionati a farsi invitare. Avanti il prossimo!